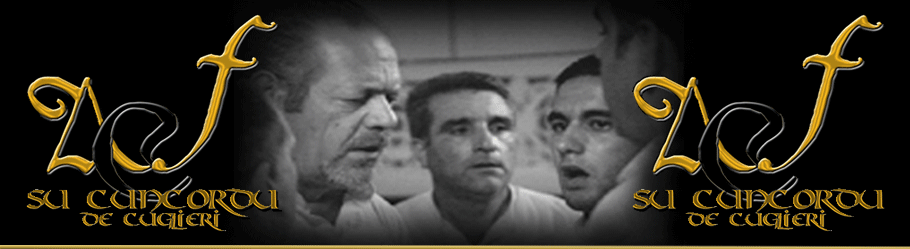Una curva dopo l’altra e un’altra ancora e poi la cresta delle montagne e sotto la sommità abbracciata da queste, e in cima la chiesa e sotto le case, una sopra l’altra, come se il gigante che aveva costruito le montagne, inciampando, le avesse rovesciate con il piede andando via. La storia poi non si è risparmiata nei secoli che furono, e forse non saranno più, se il tempo darà ragione all’ignota Cassandra che ha tracciato sul muro di una di queste case la sua oscura profezia: “Visitate Cuglieri prima che sia troppo tardi”. Chi viene da fuori forse ignora l’importanza strategica che, sin dalle epoche più remote, ha avuto quest’angolo di Sardegna, lungo la costa occidentale, dove la terra sbocca sul mare in approdi naturali, solo in pochi punti – Santa Caterina di Pittinuri č uno di questi – i soli a consentire l’ingresso nel cuore dell’isola. Così Fenici, Cartaginesi, Romani hanno lasciato segni del loro passare ovunque, dietro ogni porta, dentro ogni pietra, nell’ombra di ogni parola, su ogni volto, in particolare su quelli delle donne che qui sono davvero molto più belle dei loro uomini, tristi come vedove anche quelle sposate.
 E ancor più belle dovevano essere le loro antichissime madri se è vera la storia che le donne di Cornus, celebri per la loro avvenenza non meno che per la loro impudicizia, fecero scoppiare una guerra con la vicina Tharros, dopo aver conquistato i suoi giovani maschi.
Non valse invece il sacrificio estremo di Hampsicora e Hostus. Dopo la sconfitta del 215 a.C., vinta la resistenza sardo–punica, – Sardiniam perdomitam – Cornus e la Sardegna si avviarono a diventare romane, dopo aver descritto uno dei momenti più alti della storia sarda.
E ancor più belle dovevano essere le loro antichissime madri se è vera la storia che le donne di Cornus, celebri per la loro avvenenza non meno che per la loro impudicizia, fecero scoppiare una guerra con la vicina Tharros, dopo aver conquistato i suoi giovani maschi.
Non valse invece il sacrificio estremo di Hampsicora e Hostus. Dopo la sconfitta del 215 a.C., vinta la resistenza sardo–punica, – Sardiniam perdomitam – Cornus e la Sardegna si avviarono a diventare romane, dopo aver descritto uno dei momenti più alti della storia sarda.
Chi viene da fuori forse ignora, mentre cammina per “strade poco regolari e facili per erte e per le asprezze, e in qualche luogo per le strettezze” (Angius – Casalis), di calpestare l’ultimo strato di un palinsesto, dal quale raschiata la prima scrittura, come su una rovente lastra di fuoco, compaiono ancora incandescenti le tracce dei primi martiri cristiani, di Bizantini e Pisani.
 Durante l’età giudicale Cuglieri fece parte del Giudicato di Torres, mentre infuriava “una guerra accanitissima fra Arborea e Logudoro”. Lungo la linea di confine fra i due regni, accessibile solo da una parte, sorge il castello di Ittocorre (1160) . “Le sue molte rovine vietano di vedere i sotterranei vacui e soffocano sino alla sera, quando lo dilatano sino allo spasimo e sino all’orizzonte del mare, il canto malinconico d’una donna che s’intreccia col cigolio di un arcolaio d’oro. Una leggenda racconta infatti che fra quelle mura č racchiusa l’anima inquieta della marchesa Francesca Zatrillas, che da questo castello, dove riparò dopo l’eccidio del Viceré Camarassa, prese il mare per un esilio senza ritorno. Quell’anima è condannata ancora a dipanare nell’arcolaio d’oro quelle trame che ordì durante la sua vita, e che furono fatali a suo marito, il Marchese di Laconi, al Viceré, al venerando Marchese di Cea, ma anche a lei che morì esule e maledetta”. (Marcello Serra – “Mal di Sardegna”– Vallecchi)
Nel 1417, settantacinque anni prima della scoperta dell’America e trecentosettantadue prima della Rivoluzione Francese, il Re Alfonso d’Aragona, infeudò la “villa di Culeri” a favore del nobile Guglielmo di Montagnas, il quale poi lo alienò a Raimondo Zatrillas III. A Raimondo III, succedette Raimondo IV, di cui fu sorella Lucia “esempio di vita claustrale, consumata al servizio di Dio” (A.G.Angotzi), “piissima femmina, addetta al terzo ordine dei Servi di Maria, fondatrice del Convento dell’attuale chiesa della Madonna delle Grazie”. (Casalis)
I Zatrillas ebbero una cura particolare per il feudo cuglieritano svilupparono ampiamente la olivocultura, offrendo alla campagna intorno a Cuglieri quel paesaggio di foglie argentate d’ulivo che ancora oggi la caratterizzano.
I Serviti diffusero il culto della Vergine e furono ancora i Zatrillas a costruire e ad ampliare la chiesa della Madonna della Neve.
Durante l’età giudicale Cuglieri fece parte del Giudicato di Torres, mentre infuriava “una guerra accanitissima fra Arborea e Logudoro”. Lungo la linea di confine fra i due regni, accessibile solo da una parte, sorge il castello di Ittocorre (1160) . “Le sue molte rovine vietano di vedere i sotterranei vacui e soffocano sino alla sera, quando lo dilatano sino allo spasimo e sino all’orizzonte del mare, il canto malinconico d’una donna che s’intreccia col cigolio di un arcolaio d’oro. Una leggenda racconta infatti che fra quelle mura č racchiusa l’anima inquieta della marchesa Francesca Zatrillas, che da questo castello, dove riparò dopo l’eccidio del Viceré Camarassa, prese il mare per un esilio senza ritorno. Quell’anima è condannata ancora a dipanare nell’arcolaio d’oro quelle trame che ordì durante la sua vita, e che furono fatali a suo marito, il Marchese di Laconi, al Viceré, al venerando Marchese di Cea, ma anche a lei che morì esule e maledetta”. (Marcello Serra – “Mal di Sardegna”– Vallecchi)
Nel 1417, settantacinque anni prima della scoperta dell’America e trecentosettantadue prima della Rivoluzione Francese, il Re Alfonso d’Aragona, infeudò la “villa di Culeri” a favore del nobile Guglielmo di Montagnas, il quale poi lo alienò a Raimondo Zatrillas III. A Raimondo III, succedette Raimondo IV, di cui fu sorella Lucia “esempio di vita claustrale, consumata al servizio di Dio” (A.G.Angotzi), “piissima femmina, addetta al terzo ordine dei Servi di Maria, fondatrice del Convento dell’attuale chiesa della Madonna delle Grazie”. (Casalis)
I Zatrillas ebbero una cura particolare per il feudo cuglieritano svilupparono ampiamente la olivocultura, offrendo alla campagna intorno a Cuglieri quel paesaggio di foglie argentate d’ulivo che ancora oggi la caratterizzano.
I Serviti diffusero il culto della Vergine e furono ancora i Zatrillas a costruire e ad ampliare la chiesa della Madonna della Neve.
 Nel 1642 era nata a Cuglieri Francesca Zatrillas, e nel 1661 ereditò il feudo, diventando Contessa di Cuglieri e Marchesa di Siete Fuentes. Dopo aver sposato a 23 anni (1665) lo zio Agostino di Castelvì, Marchese di Laconi, quando questo venne assassinato, fu sospettata di essere la mandante dell’omicidio. Un mese e mezzo dopo venne ucciso anche il Viceré Marchese di Camarassa, fiero antagonista del Castelvì.
Finita in un gioco più grande di lei, nel contrasto che opponeva la nobiltà sarda alla Corona Spagnola, Francesca Zatrillas lasciò Cagliari per rifugiarsi a Cuglieri nel suo feudo.
Qui, “con meravigliosa sfacciataggine e licenziosa indecenza (Casalis), Donna Francesca tiene capriccio con Silvestro Aymerich”. Così in una lettera anonima, datata Cuglieri 5 settembre 1688; i cuglieritani hanno da sempre una vera passione per la scrittura, inviata al Marchese di Cea, capo ormai riconosciuto della famiglia, il quale inviava a Cuglieri il Cappuccino Fra Giuseppe di Cagliari. Questi “portatosi alla residenza della Marchesa la trovò illuminata e disposta come se in essa si dovesse preparare una festa: allegre dame giocavano a carte la stessa Francesca Zatrillas si esercitava alla chitarra. Ciò che maggiormente scandalizzò il Cappuccino fu che le finestre della casa erano tanto aperte in modo che i vicini potevano vedere tutto quanto si faceva all’interno”.
Non conosciamo, perché la grande storia non conserva la memoria degli ultimi, come giudicassero nel Seicento i cuglieritani Donna Francesca, resta il fatto che è rimasta in loro molta di quella leggera gioia di vivere, l’amore per la musica e per il canto, la spavalderia di una donna che nel Seicento scriveva – (Cuglieri 13 ottobre) – al Marchese di Cea: “che pensasse egli ad aggiustare le sue faccende, e, la lasciasse in pace”.
Nel 1642 era nata a Cuglieri Francesca Zatrillas, e nel 1661 ereditò il feudo, diventando Contessa di Cuglieri e Marchesa di Siete Fuentes. Dopo aver sposato a 23 anni (1665) lo zio Agostino di Castelvì, Marchese di Laconi, quando questo venne assassinato, fu sospettata di essere la mandante dell’omicidio. Un mese e mezzo dopo venne ucciso anche il Viceré Marchese di Camarassa, fiero antagonista del Castelvì.
Finita in un gioco più grande di lei, nel contrasto che opponeva la nobiltà sarda alla Corona Spagnola, Francesca Zatrillas lasciò Cagliari per rifugiarsi a Cuglieri nel suo feudo.
Qui, “con meravigliosa sfacciataggine e licenziosa indecenza (Casalis), Donna Francesca tiene capriccio con Silvestro Aymerich”. Così in una lettera anonima, datata Cuglieri 5 settembre 1688; i cuglieritani hanno da sempre una vera passione per la scrittura, inviata al Marchese di Cea, capo ormai riconosciuto della famiglia, il quale inviava a Cuglieri il Cappuccino Fra Giuseppe di Cagliari. Questi “portatosi alla residenza della Marchesa la trovò illuminata e disposta come se in essa si dovesse preparare una festa: allegre dame giocavano a carte la stessa Francesca Zatrillas si esercitava alla chitarra. Ciò che maggiormente scandalizzò il Cappuccino fu che le finestre della casa erano tanto aperte in modo che i vicini potevano vedere tutto quanto si faceva all’interno”.
Non conosciamo, perché la grande storia non conserva la memoria degli ultimi, come giudicassero nel Seicento i cuglieritani Donna Francesca, resta il fatto che è rimasta in loro molta di quella leggera gioia di vivere, l’amore per la musica e per il canto, la spavalderia di una donna che nel Seicento scriveva – (Cuglieri 13 ottobre) – al Marchese di Cea: “che pensasse egli ad aggiustare le sue faccende, e, la lasciasse in pace”.
 La storia di Cuglieri, di questo paese che sin dal nome richiama al maschile è storia di donne.
Scrive il Casalis – “Spregiano queste femmine il panno che esse fabbricano, vogliono le stoffe straniere e le tele dipinte, e van lasciando le antiche mode di vestire”. Non discendono dall’ostinata Penelope le figlie di queste antichissime madri, ma dalle cornuensi “eccessivamente dedite al lusso”.
La storia di Cuglieri, di questo paese che sin dal nome richiama al maschile è storia di donne.
Scrive il Casalis – “Spregiano queste femmine il panno che esse fabbricano, vogliono le stoffe straniere e le tele dipinte, e van lasciando le antiche mode di vestire”. Non discendono dall’ostinata Penelope le figlie di queste antichissime madri, ma dalle cornuensi “eccessivamente dedite al lusso”.
Cuglieri è “pazzosa”, (per chi scrive è una virtù) espressione intraducibile, occorre esservi nati e avere molte generazioni alle spalle per comprenderla e, molta di più ancora per esserlo. Fiera del suo “latinorum” unica eredità rimasta del grandioso Seminario, anche quando inventa, tra i fumi dell’incenso, hapax surreali ai limiti della decenza; naturalmente colta perché anche i meno “culturati”, da sempre sanno conferire al sapere un rispetto che altrove manca; poco ospitale perché la casa è un luogo sacro alla cui inviolabilità si deve essere ammessi e non si apre facilmente; triste, perché qui l’acqua fa dimenticare; dolce nella sua parlata logudorese, ricca di “za”, di “finesas” e di “delicadeas de feminas” che si incendiano di bagliori di fiamma nella voce maschile de “su contraltu” e sprofondano in canto.
Basta essere a Cuglieri durante la Settimana santa e ascoltare la sequenza dolorosa dello Stabat Mater e il grido del Miserere. Un coro di voci maschili, disposto a semicerchio, al centro “su bassu”, a sinistra “su contraltu”, a destra su “tenore”, e quasi in disparte “su tenore falzu”, cammina e canta, si ferma e sale, insieme a una folla immensa e invisibile su quel Golgota naturale che è il monte Bardosu, là, dove in una cassa era stato portato il corpo immenso della madre, ora, Venerdì Santo portano il corpo misero del Figlio.
Quis est homo qui non fleret, Matrem Christi si videret in tanto supplicio? Chi non piangerebbe a vedere la madre in tanto supplizio? E senza più fiato, urtandosi, e senza più occhi le donne accorrono sotto la Croce (sa vera rughe) a deporre ognuna il lume per il proprio defunto. A grandi passi si avviano mentre viene innalzata l’altra Croce, quella de S’Ingravamentu, perché soltanto un’anima verrą salvata l’anima di colei che sarà riuscita a poggiare per prima la luce.
La sera, il corpo del Cristo verrà liberato dalla croce, sorretto dalle bende verrà mostrato alla Madre, deposto nel suo letto di morte sarà portato al sepolcro. Miserere mei Deus, secundum magnam misericordiam tuam et secundum multitudinem miserationum tuarum dele iniquitatem meam. Pietà di me mio Dio, secondo la tua misericordia nella tua grande pietà cancella il mio peccato. E sembra di vedere le povere ossa, di tutti quelli che non hanno avuto il proprio lume essere poggiato per prima per terra, cercare la loro carne, risvegliati dalle voci, salvati dal canto. Sa vera rughe e quella de S’Ingravamentu vengono caricate in spalla. Si percorre la stessa via del Cristo morto; preceduti da un confratello, che battendo per terra, forte, un bastone, ad alta voce dà “Su passu” ai confratelli che portano le croci, la gente si sparpaglia, nelle vie strette s’appoggia ai muri delle case alte, si ricompone. Poi, riprende il Calvario, si affretta a ritrovare il canto, ma il canto è ormai lontano, giù, in fondo al paese nel grembo di pietra di Piazza Convento.
(Piera Perria – Audiolibro “Te Deum laudamus”, Ed.Frorias 2008)