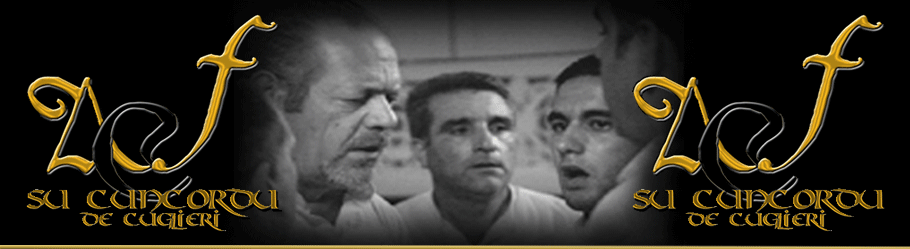Soprattutto in questi ultimi tempi, una sempre più attenta politica di interesse nei confronti delle culture locali, ha portato gli appassionati a rivedere la storia dei singoli paesi sotto nuove e più brillanti prospettive.
In questo percorso, si inserisce la riesumazione dell’antico carnevale rituale, che costituisce una tappa fondamentale nella comprensione dei significati della complessa religione paleosarda, di cui il carnevale risulta, per l’appunto, una evidentissima icona.
Elidendo qualsiasi giudizio di chi abbia o meno usato ed abusato della tradizione del carnevale, qualsiasi tentativo di riesumare le figure del carnevale culturale risulta lodevole e meritorio.
In questo sforzo immane, a dare man forte ai ricercatori, arrivano i testi del padre gesuita Bonaventura Licheri, che, come in precedenza ad Ortueri, Atzara, Cheremule, Austis e Samugheo, ed inseguito a Mamoiada e ad Ottana, visita Cuglieri in occasione della festa di S.Antonio Abate (17 gennaio) e descrive la partecipazione delle maschere alla festa nella poesia intitolata “Gurulis Nova Sant’Antoni in s’ierru” datata 1773.
Il Licheri scrive sull’onda dei ricordi, la visita è avvenuta tempo prima, giacché in questa data la Compagnia di Gesù fu soppressa dovunque e pertanto pare che lui fosse tornato già allo stato laicale.
Questo componimento va ad inserirsi, all’interno dell’opera del frate, al vasto repertorio delle invettive col quale, in modo non tanto velato, lo stesso autore denuncia la commistione tra le liturgie cattoliche ed i retaggi della cultura pagana.
E lo fa ponendosi a servizio, da quanto si evince dagli scritti, di una fra le più emblematiche figure del 700 sardo: il gesuita Giovan Battista Vassallo. Questo personaggio, piemontese di nascita, si distinse per lo zelo con cui difese le prerogative dei gesuiti all’epoca dello scioglimento dell’ordine, ma soprattutto per l’apostolato che svolse visitando, a piedi, i paesi di mezza Sardegna; motivo per il quale morì in concetto di santità.
Fa discutere questa frase del componimento poetico “…unu corru in chizzos presu apedde crua”:
un corno sulla fronte legato con la pelle cruda.
Scrive la Professoressa Dolores Turchi “… è quella (riferita alla maschera) che mi ha dato più da pensare in quanto si differenzia parecchio da tutte le altre. Posso comprendere l’aggiunta delle cotzulas (conchiglie) e l’argilla gialla in faccia. Sappiano che anche il giallo in Sardegna era considerato un colore luttuoso. In alcune località lo si č usato sino alla fine dell’Ottocento.
Queste due cose possono avere una giustificazione e rientrare pienamente nel quadro dionisiaco che si evidenzia in tutte le maschere. E’ però incomprensibile la questione dell’inicorno, un animale fantastico al di fuori di ogni realtà e di ogni rituale. Non trovo nessun argomento che giustifichi la sua presenza. Non mi risulta un elemento simile in nessuna maschera del Mediterraneo.
Tutto mi induce a credere che si trattasse di una sorta di parodia dell’antica maschera di Cuglieri (che non doveva essere dissimile dalle altre almeno negli elementi essenziali), molto probabilmente suggerita dagli stessi gesuiti che in paese dovevano essere numerosi. Insomma, un modo di travisare l’aspetto dell’autentica maschera perchè col tempo si confondessero le idee e ci si allontanasse sempre più dal modello primitivo, cancellandone a poco a poco il ricordo. Questo stravolgimento in quel periodo fu fatto ad opera della Chiesa per tante tradizioni sarde; era il modo più intelligente per dimenticare gli ultimi strascichi di paganesimo. Molto probabilmente il Licheri capitò a Cuglieri proprio in quegli anni di transizione…”.
Nel n. 25 della rivista “Sardegna Mediterranea” (IRIS Ediz.Aprile 2009) la professoressa Turchi ha pubblicato l’articolo “ANCHE CUGLIERI RICOSTRUISCE LA SUA MASCHERA” nel quale fa un esame critico del mascheramento dei Cotzulados.